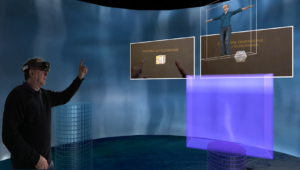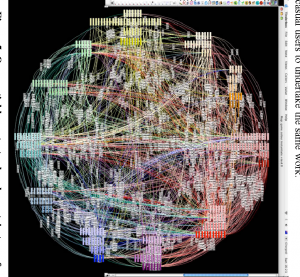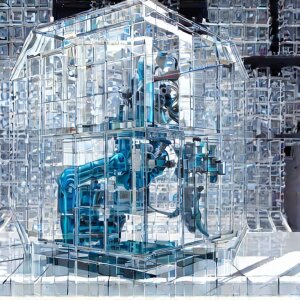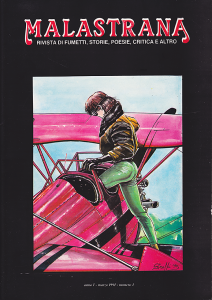|
Rientrando in casa vidi subito la busta sul tappeto nell'ingresso. Senza francobollo, senza indirizzo. La raccolsi e la aprii lentamente, poi lessi le poche righe scritte in una calligrafia stentata.
Sono certa che Alina sarebbe felice di vederti ora. Qualcosa è successo, qualcosa è cambiato in lei. Vieni a trovarla, ti prego.
Sono sicura che la faresti felice.
Per favore vieni...
Sarah
Turbato rimasi a lungo con il foglio in mano, lo rilessi tre volte cercando tra le righe il senso del messaggio. Poi appoggiai il foglio sul tavolo.
Alina.
Alina, le lettere del suo nome scandite su carta accesero in me le immagini che lei mi aveva inciso nella memoria, quando l'avevo vista per l'ultima volta, l'ultimo contatto tra noi: a letto, appena svegli. Col mio braccio attorno al suo collo, con la luce che filtrava oltre le tende e accarezzava le linee dolci del suo profilo, le labbra lucide. Mentre i suoi occhi aperti puntavano al soffitto. Quando si era girata dalla mia parte e mi aveva guardato a lungo prima di parlare. Quando aveva detto che non voleva più vedermi né sentirmi, con la determinazione di chi ha già deciso e semplicemente si limita a esporre l'innegabile evidenza di un fatto.
Aveva conservato dentro tensioni e rancori, insofferenze e indifferenze; una dopo l'altra, un giorno dopo l'altro. Come rocce appoggiate su una lastra sottile di ghiaccio. In silenzio, senza perdonarmi nessuno dei miei errori, nessuno dei difetti. Quella mattina la crosta che conteneva i suoi pensieri aveva ceduto; in un istante, ciò che ci univa si era trasformato in ciò che determinava il nostro separarci.
Le cose cambiano, mi aveva detto, i sentimenti si trasformano. Mi aveva spiegato tutto con lentezza, mentre io continuavo a spostare i miei occhi dai suoi occhi alle labbra e ai suoi occhi di nuovo, in cerca di un legame tra le sue parole così impensabili per me fino a pochi istanti prima e il ricordo dei momenti in cui avevo accarezzato la sua lingua con la mia, e colto il sapore dei suoi baci liquidi. Poche ore appena, indietro nella notte.
Era stata l'ultima occasione che mi aveva concesso, quella. La sola in cui ero riuscito a domandarle le cause del suo negarsi improvviso. La sola in cui mi aveva offerto spiegazioni che avevo dovuto rassegnarmi ad accettare.
Senza capirle, però.
Non l'avevo più rivista. Ma volevo farmi del male, così l'avevo cercata al telefono. Ogni volta con lo stesso risultato: la sua rabbia immediata, molta rabbia, rabbia eccessiva. E parole dure, che colpivano fredde, cariche di crudeltà inutile. Sparisci! mi dicevano quelle parole. Via!
Non l'avevo più chiamata.
Però a lungo e invano avevo atteso lo squillare del telefono, il suono della sua voce. A lungo e invano avevo sperato di ricevere lettere in risposta a quelle che le avevo scritto. Giorno dopo giorno dopo giorno.
Ma niente.
E ora invece questa lettera...
Questa lettera spezzava il silenzio e i quattro mesi di lontananza che si erano accumulati tra noi. Troppo in fretta mi riportava indietro nel tempo a quei gesti e parole e sguardi e sorrisi e carezze di cui avevo cominciato a comprendere la necessità soltanto dal momento in cui mi erano stati negati.
Ci rimasi a lungo in piedi in cucina, davanti al tavolo, fisso sul foglio aperto appoggiato sul tavolo. Per favore vieni...
Mi ero sforzato di credere che la mia indifferenza per Alina avesse la stessa concretezza dell'indifferenza che lei aveva dimostrato per me. Ma era inutile. Sciocco. Ero ancora stregato da quella forza che aveva acceso in me il desiderio di lei fin da quando ci eravamo incontrati.
Certo.
Il desiderio di lei si era fatto necessità. Aveva frantumato la mia razionalità, macinato tutto dentro. Triturato. Era diventato altro: perdita, mancanza, un vuoto nero.
Non volevo andare. Un nuovo incontro con Alina avrebbe sfaldato la consistenza del ruolo che avevo recitato ogni giorno con me stesso cercando di soffocare con la ragione il potere distruttivo dei sentimenti. Ma mezz'ora più tardi ero in strada e camminavo verso la sua casa, con l'ansia per la visita imminente, irritato per la magia inquieta che mi costringeva a cercarla, in lotta contro una voce in me che voleva costringermi a ignorare la lettera e continuare nella finzione dell'indifferenza.
Era sera ormai. Era freddo, nuvole grigie e compatte affollavano il cielo; nell'aria il profumo di neve in arrivo. Attraversai il parco davanti casa, l'erba gelata mi scricchiolava sotto ai piedi. Lungo la sponda del lago già cominciava il viavai consueto di macchine e uomini in cerca di compagnia e sesso.
Percorsi strade, incroci, altre strade fin quando infilai la discesa tra gli alberi, verso casa di Alina. Lì davanti mi fermai e rimasi immobile, come una costruzione di ghiaccio, indeciso se andarmene o restare.
Ma suonai, alla fine.
Da oltre la porta percepii un fruscio di passi, lo scricchiolio dei pavimenti di legno, gli scatti metallici della serratura, e quando la porta si aprì vidi il volto magro della madre di Alina. La udii bisbigliare il mio nome mentre deformava le labbra in un tentativo di sorriso. E poi si scostò per lasciarmi entrare, con un gesto così consueto che per un attimo mi colse il pensiero che i miei quattro mesi di assenza da questa casa fossero semplicemente il frutto di un sogno troppo lungo da cui soltanto ora mi svegliavo.
Nell'oscurità il corridoio mi apparve più stretto di come lo ricordavo, e io proseguii incerto nel buio con la sensazione di infilarmi nella gola di un rettile addormentato. Mi fermai in fondo. Dal piano superiore arrivavano suoni dissonanti e cupi, di sicuro Victor che si esercitava al piano. Le note si infilavano invisibili attraverso le pareti e ne uscivano filtrate e distorte.
Immobile nel buio notai la presenza di un odore strano: penetrante e acido, e diverso da qualsiasi altro odore che conoscevo. Con gli occhi ne cercai la fonte, ma fui distratto dallo strisciare dei passi della madre di Alina verso di me, dal tocco morbido della sua mano sulla mia spalla destra, dal contatto lieve dell'altra mano sulla sinistra. Mi spinse in avanti con una pressione leggera delle dita fino nel soggiorno. Lì dentro, una scena vista altre volte: suo marito sprofondato nel divano davanti alla televisione, un bicchiere in mano, i piedi accavallati sul tavolino vicino ad una bottiglia di vino. Ci vide arrivare e si voltò verso di noi, poi prese a guardarmi e aprì la bocca come per parlare, ma alla fine rimase muto, congelato per istanti in quella posizione sospesa. Tornò a concentrarsi sullo schermo.
Allora mi voltai verso la madre di Alina ora esposta alla luce e mi accorsi che durante i mesi della mia assenza la forza del tempo si era impossessata di lei e graffiato anni sul suo viso. Di sicuro era diversa da come la ricordavo: vedevo occhi spenti ora, e uno sguardo di donna rassegnata, disposta al dolore.
Guardai i suoi capelli spettinati, quel biondo pallido che sbiadiva nel bianco, colsi i tratti spigolosi del suo naso, e le rughe che incidevano le guance e si aprivano ai lati della bocca. E vidi occhi rossi, e il gonfiore attorno agli occhi, e tracce di pianti recenti e frequenti. Doveva essere successo qualcosa. Sì, qualcosa ad Alina...
Inquieto, continuai a fissarla sperando che fosse lei a parlare e rispondere alle domande che io le avevo silenziosamente formulato dentro di me. Ma lei ricambiava le mie occhiate, solo quello. E io non potevo che rimanere così, muto di fronte a lei, incapace di trovare le parole adeguate per aprire la conversazione.
Finalmente mi indicò il tavolo con un gesto della mano, e una sedia. «Come va?» mi chiese mentre sedevo, con una gentilezza forzata che riuscì solo ad aumentare il mio imbarazzo.
«Bene» risposi. Sorrisi poco convinto. «Sì, insomma, abbastanza bene.»
«Sei dimagrito molto» disse allora facendo scorrere i suoi occhi su di me, e riuscì subito a irritarmi con quella sua occhiata rapida e con la sua frase assolutamente fuori luogo.
«Sì, lo so» risposi. «Lo so, me lo dicono tutti, ma non è niente. È che ultimamente non... Ma no... sì, sono dimagrito un po', ma non è niente» conclusi velocemente, provando a minimizzare la cosa con la speranza di riuscire a cambiare argomento.
Certo, ero dimagrito, ma che potevo farci se perdevo peso? Sei magro, sei proprio dimagrito, dovresti mangiare, mangiare! Me lo diceva lo specchio, me lo sentivo ripetere e ripetere da tutti ormai. E ora anche lei...
Ma non ero venuto qui per sentirmi dire cose che già conoscevo; non era questo che volevo ascoltare ora. Alina, volevo sapere di Alina. Alina. Ma doveva essere lei a cominciare e dirmi e spiegarmi.
«Vuoi qualcosa da bere?» domandò.
Scossi la testa. «Dov'è Alina?» chiesi, troppo impaziente per trattenermi ancora. Mi guardo a lungo prima di parlare. I suoni del pianoforte si intromettevano tra noi, costruivano distanze. Ripetei la domanda a voce più alta.
«Dov’è?»
«Alina è malata» disse. «Molto malata.»
«Malata come?»
«Non sono riusciti a capirlo esattamente.» Puntò i suoi occhi nei miei. Alina, aveva gli stessi occhi: sfumature di verde luminoso immerse nell'azzurro profondo. Abbassai per un attimo lo sguardo a terra, nelle geometrie indifferenti del tappeto. Turbato.
«È successo tutto così d'improvviso...» continuò. «Sono venuti a visitarla, abbiamo chiamato diversi dottori... Una disfunzione dicono, ma non sanno spiegare... dire cosa...»
«Dov'è?» chiesi ancora, nervoso, alzando la voce più del necessario.
«Non sanno spiegare» ripeté senza rispondermi. Era come se io non ci fossi.
«Anche la sua mente è... lei è diversa ora, non è più come prima, è cambiata...» Si fermò di nuovo e continuò a fissarmi senza parlare. Queste sue pause mi gonfiavano l’irritazione dentro.
Se ne accorse. «È in camera sua» disse puntando un dito verso l'alto.
«È stata lei a chiedere di vedermi?» domandai.
«No» rispose senza esitazione. «No, sono stata io. Ho pensato che forse le avrebbe fatto piacere vederti...»
Non era stata Alina. Naturalmente. Chiaro, non era stata lei, solo io potevo essere stato così sciocco da illudermi che la malattia l'avesse cambiata, che lei avesse pensato che io...
«Vorrei che tu la vedessi» mi disse sua madre. E mi scavò una strada dentro con gli occhi. Era una strada che parlava di dolore e altro che non potevo capire. E continuò: «Vorrei che tu potessi parlarle. Lei è così diversa ora, è sempre più difficile comunicare con lei, e io non so se... Vorrei solo che tu riuscissi a parlarle.»
«Ma che le è successo?» mi sentii domandarle. «Che significa che è cambiata? Che malattia ha?» chiesi, e scattai in piedi e stavo quasi urlando.
Lei non mi rispose, ma le intuii un tremore sulle labbra, e i suoi occhi erano lucidi. Così un disagio crescente prese ad accumularsi in me con l'accumularsi dei secondi di silenzio tra noi. Per un tempo interminabile restammo uno di fronte all'altra, immobili.
«Posso vederla?» domandai alla fine.
Mi rivolse un sorriso sbiadito e annuì. Allora
mi diressi verso la camera di Alina senza aggiungere parole.
Mentre salivo le scale osservai le foto di famiglia attaccate alla parete: Alina, capelli lunghissimi, rideva in groppa ad un cavallo nero. Fierissima, bocca spalancata. Poi, Alina in riva al mare: che correva sulla spiaggia lanciando nuvole basse di sabbia attorno ai piedi, un attimo prima di afferrare il fratello in corsa davanti a lei. E ancora, Alina ridente tra i suoi genitori: alle spalle una scena di campagna, verdi, gialli sfuocati; e sua madre più giovane, ancora bella; e suo padre che sorrideva, ancora lontano dai guai, lontano dalla bottiglia.
Alina...
Un flusso di ricordi mi assalì con la furia di una bestia selvaggia. Ricordi vicini. Forti. In quei ricordi c’era un vino bevuto davanti alla televisione inutile, abbracciati nel divano, a baciarsi. E dopo, mentre la toccavo. O dopo ancora, con gli inseguimenti rumorosi su per queste scale; un bicchiere rotto sul pianerottolo, rumore di vetro che si spacca, e ridere, frammenti di vetro attorno ai nostri piedi, vino rosso cupo fuso col rosso del tappeto. E ancora: c’era il gioco dell'inseguirsi, le nostre ombre che si rincorrevano e intrecciavano, l'afferrarsi e lo stringersi, e le mani, le dita che si chiudevano, col desiderio che prendeva i nostri corpi. I contatti ansiosi prima dell'amore, gli scivolamenti e le carezze. Ricordo un movimento di capelli anche, il ruotare lento di ciuffi di capelli che riempivano lo spazio davanti ai miei occhi...
D’improvviso l'idea di rivederla mi riempì d'apprensione, di paura. Non ero preparato per questo incontro. Alina mi aveva scacciato dalla sua vita col gesto indifferente di chi allontana un insetto. Ora era malata, cambiata, e io dovevo visitarla e usare con lei una gentilezza che lei mi aveva negato. Perché rivederla, e riaprire quel varco sul silenzio che aveva imposto la distanza tra noi, come se questa distanza potesse essere colmata, cancellata?
Mi arrestai e volevo andarmene, volare via da quella casa come un fantasma invisibile.
Eppure mi trattenni. Non riuscivo a dominare quel desiderio che mi spingeva a volerla rivedere, e sapere cosa le stava accadendo. Parlare ancora con lei, ascoltare la sua voce, esserle vicino; questo volevo. Solo questo.
Salii gli ultimi scalini e mi avvicinai alla camera. La porta era aperta. Entrai. La stanza era avvolta nella penombra.
Quell'odore pungente che già avevo notato appena entrato in casa mi afferrò ora più violento; ricordava erbe marcite nella pioggia, o il pelo bagnato di animali. Ma subito dimenticai l'odore, perché vidi Alina seduta nel letto, china su qualcosa che reggeva tra le mani. Incerto, imbarazzato, mi avvicinai per salutarla, ma come fui in prossimità del letto le parole mi si bloccarono in gola e provai l'improvvisa e terribile sensazione che Alina stesse continuando quel gioco crudele con le mie emozioni iniziato nel momento in cui mi aveva eliminato di colpo dalla sua vita. Era uno scherzo quello che mi stava facendo, doveva essere uno scherzo...
Tra le lenzuola, avvolto come in un bozzolo, c'era il corpo enorme di una donna che non conoscevo. Quella donna non era lei, non poteva essere lei.
Mi avvicinai ancora e così riuscii a vederla meglio alla luce fioca della lampada, e mi accorsi che era proprio lei, Alina credo. Ero quasi certo che fosse lei, anche se non riuscivo a capire, non era possibile che in pochi mesi le fosse successo questo, non era possibile...
La guardai. Non potevo fare a meno di tenere gli occhi su quella creatura. Era ingrassata. A dismisura. Completamente diversa da come la ricordavo, completamente.
Alina non alzò neppure la testa. Per terra, attorno al letto e sul letto, decine di fogli di carta, alcuni strappati, altri appallottolati, altri riempiti con righe fitte di parole. Come in un caotico arcipelago di carta. E lei era seduta sul letto, appoggiata con le spalle al muro, la testa che toccava quasi il soffitto in pendenza. E lei era china e presa e persa nell'atto di scrivere senza posa su un foglio, l'oro nei suoi capelli che nascondeva in parte la carne che annullava i tratti del suo volto.
Sopraffatto da quella visione non sapevo più cosa dire o fare. Lanciai occhiate intorno, alla stanza, ai mobili, alle cose di Alina che spesso avevamo usato assieme e che ora erano lì tra noi come testimoni di un passato irrecuperabile. Nella stanza accanto Victor continuava a suonare il piano e le note si imponevano chiare nel silenzio. Cercai di immaginare le sue dita scivolare velocemente sui tasti come zampe affilate di ragni frenetici. I suoni mi inondavano, danzavano attorno e si appoggiavano sugli oggetti e si dissolvevano.
E guardai Alina. La guardai a lungo.
Catturato nel groviglio di suoni, afferrato dai ricordi, invano cercai di formulare pensieri adeguati, di materializzarli in significati, in parole. Il tempo mi sembrò sospeso.
«Ciao» le dissi alla fine. A disagio, sottovoce, cercando di concentrarmi nei suoi occhi, evitando di scorrere il mio sguardo sull'ammasso di carne che era diventata. Per una frazione di secondo lei alzò la testa verso di me e non riuscii a riconoscerla quasi, ma sapevo che era lei perché i suoi occhi mi sfiorarono e ne afferrai la luce verde, le tonalità azzurre. Un attimo, uno sguardo veloce, senza interesse, come quello di un cieco che finge di concentrarsi sulla direzione di un suono senza veramente essere in grado di identificarlo. Poi ritornò al foglio e alle parole.
«Ciao» dissi di nuovo, ancora più a disagio. Ma lei non mi degnò neppure di un'occhiata e continuò a scrivere.
Mi sentii ridicolo. Volevo andarmene, dimenticare questo.
Invece con lo sguardo indugiai sul suo corpo cercando di individuarne i contorni nascosti dalle lenzuola. Mentre scriveva le sue braccia nude tremavano come masse di gelatina, le sue dita ora tozze stringevano lo penna e la nascondevano quasi.
«Mi sei mancata» dissi allora, e subito la vergogna mi assalì per la stupidità di una frase così assurda in un momento come questo, e che pure mi era sgusciata di bocca con la velocità insidiosa di un serpente.
Al suono delle mie parole lei smise di scrivere, alzò lo sguardo verso di me, e sbuffò e dischiuse le labbra e rise, emettendo un suono rauco che fino a pochi mesi prima non le apparteneva. Poi riabbassò la testa. Solo per un attimo colsi la visione dei suoi denti bianchi e perfetti, come gioielli d'avorio, non intaccati dalla mutazione che aveva gonfiato il suo corpo. Cercai di cancellare l'immagine che di colpo affiorò alla mia mente alla vista dei suoi denti, l'immagine di noi in questa stanza, lei tra le mie braccia, il suo corpo snello stretto nel mio, le mie labbra contro le sue, la lingua che scorreva tra quei suoi denti lucidi. No, non era lei, no, non era più lei, non era più lei...
Alina mi ignorava, proseguiva in quel suo scrivere ossessivo; riempito il foglio che aveva tra le mani lo appallottolò e lo lanciò a terra. Si girò verso il comodino, aprì il cassetto ed estrasse un altro foglio e un attimo dopo stava già scrivendo.
Il silenzio materializzò la distanza tra noi, l'incolmabile abisso che i miei occhi percepivano e che la mia mente ancora si rifiutava di accettare. Allora non so cosa mi prese; una forza ignota trovò spazio dentro di me. Era come una luce improvvisa. La sentii prendere possesso del mio corpo, scegliere i miei pensieri e guidare il moto delle mie gambe. Così mi alzai, mi mossi verso il letto calpestando i fogli scagliati a terra mentre un desiderio disperato per Alina mi colmava. Ero incapace di sopprimere il riaffiorare di mille immagini di lei. Volevo riaverla come era un tempo, così come mi appariva nella memoria.
Non so cosa mi prese; d'un tratto ero in piedi, preda di un incanto che mi trascinava verso di lei e mi accecava, sovrapponendo nei miei occhi il fantasma di lei a quell'ammasso indifferente di carne che mi giaceva davanti, lanciata come un uccello impazzito verso una distanza infinita, via da me, lontano da se stessa.
Mi alzai, mi avvicinai mentre lei continuava a scrivere, e allungai una mano verso il lenzuolo che la nascondeva e glielo strappai di dosso, lo scagliai in aria e poi lo lanciai a terra.
La sua camicia da notte era arrotolata attorno alla vita; incredulo, incapace di esprimere parole, restai davanti alla sua nudità improvvisa, inorridito alla vista di quei rotoli di carne rosa e luminosa e impregnata di sudore che avvolgevano e sopprimevano i contorni delle sue gambe trasformandole in alberi morbidi, indefinibili.
L'odore del suo corpo umido, lo stesso odore dolciastro che avvolgeva la casa, mi afferrò. Pungente. Solo a fatica riuscii a trattenermi dall'allontanarmi. Mentre fissavo la macchia di pelo scuro attorno al suo sesso seppellito nell'intreccio di carni cadenti dal ventre e dalle cosce, percepii i suoi occhi su di me. Alzai lo sguardo, e i suoi occhi erano puntati nei miei: verdi, immersi nell'azzurro, come pietre nascoste nell'eccesso che era diventato il suo volto.
Mi guardo, a lungo questa volta, mentre un sorriso le piegava la bocca in una smorfia. «Cosa vuoi ancora da me?» disse; la sua voce era cambiata: cupa, rauca. «Lo so perché sei qui!» continuò senza neppure aspettare la mia voce. «Ti piaccio ancora vero? Dì, non è vero che ti piaccio ancora?»
Si girò verso il comodino, verso la lampada. «È ancora innamorato di me, poveretto!» disse, e questa volta le parole erano rivolte alla stanza, alla luce. «È ancora innamorato, come un idiota, dopo tutto questo tempo, come se io non avessi altro a cui pensare che ai suoi stupidi problemi!»
Fece una pausa, tornò a guardarmi, i suoi occhi socchiusi fissi nei miei come a volerli penetrare. «Che stupido sei... devi essere proprio stupido per perdere ancora il tuo tempo con me!» disse, e poi cominciò a ridere, un suono ansimante, rideva con la bocca spalancata, i denti luccicanti, la lingua che le saettava nel palato come la testa rossa di un serpente vivo nella sua gola. «Poveretto...» ripeteva tra le risa, «povero stupido!» e il suo corpo intero tremava negli spasmi del riso. Era una montagna di carne scossa da un terremoto violento.
Poi smise di colpo.
«Cosa vuoi ancora?» mi urlò addosso. «Non vedi come mi hai ridotta! Non ti basta questo?» disse, e mi guardo con gli occhi spalancati, la bocca aperta, e in quel momento capii che l'avevo persa per sempre e allora sentii la tristezza farsi solida e amara, e salirmi in gola rapidissima, e volevo fuggire da lì, andare via, e già stavo per muovermi verso la porta quando Alina si scosse con un scatto, mi afferrò per un braccio e mi tirò verso di sé. Cercai di trattenermi, ma non riuscii a divincolarmi e caddi sul letto e su di lei. Le sue braccia e gambe mi si stringevano attorno, percepii il gonfiore del suo corpo contro il mio e potevo sentire le sue dita frugarmi la schiena in cerca della pelle sotto al vestito. E poi il dolore lancinante delle sue unghie in me. Mi penetravano nelle spalle. Mi stringeva contro di lei e premeva, ero sempre più avvinghiato a lei, come in una morsa, mentre la carne umida e calda del suo corpo massiccio sembrava volersi spalancare attorno a me e avvolgermi e inghiottirmi e nascondermi dentro di lei.
Le sue labbra aperte mi cercavano il collo, la sua saliva mi bagnava la pelle, lei mi succhiava con violenza mentre con i denti affondava nella mia carne. La mia testa si perdeva nei suoi capelli.
«Vieni, vieni con me!» mormorò. «Facciamola finita una volta per tutte!» disse. Provai a staccarmi da lei, ma lei mi tratteneva stringendomi sempre più forte, e urlava e rideva e continuava a succhiarmi il collo, e rideva e stringeva, e io sentivo il respiro mancarmi. Sprofondavo in lei, nel suo corpo che si fondeva col mio
.
Con un gesto disperato le afferrai la faccia con entrambe le mani premendo le dita nei suoi occhi e cercai di spingerla via con le poche forze che mi erano rimaste. Allora lei lasciò la presa sul mio corpo e mi scagliò contro il muro, lontano dal letto.
Ci fu un istante in cui restammo a guardarci. I suoi graffi mi bruciavano la schiena come fuoco. Mi infilai la camicia nei pantaloni. Sentivo le braccia molli, le gambe quasi incapaci di sorreggermi. In quell'abbraccio l'energia del mio corpo mi era stata succhiata via. Era evaporata, assorbita dalla sua carne sudata.
Mi guardo negli occhi e mi urlò: «Perché non te ne vai ora? Mi hai visto, no? Hai avuto ciò che volevi! Non sei contento ora? Non vedi che ho da fare? Non posso perdere il mio tempo con te! Perché non te vai, eh? Và via! Via!»
Poi, come se il nostro incontro fosse soltanto il frutto di un suo sogno ormai dimenticato, si agitò appena nel letto e riprese a scrivere con un gesto tranquillo.
Abbassai gli occhi. A terra c'era il lenzuolo; mi chinai, lo afferrai e glielo lanciai con un gesto rapido del braccio. Mentre compivo quel movimento, per un attimo colsi la mia immagine nello specchio alla parete, e provai la sensazione che quegli occhi lucidi che mi guardavano, quei capelli arruffati, quei tratti pallidi la cui magrezza era accentuata ora dalla penombra, non appartenessero a me, ma fossero di qualcuno che non conoscevo e che ci aveva spiati in silenzio al di là del vetro.
Fu un istante soltanto, ma mi venne spontaneo l'alzare un braccio verso il mio viso e sfiorarmi le guance incavate, e cercare quel gesto riprodotto nella mia copia nello specchio.
Fu un istante soltanto. Poi andai verso la porta senza girarmi indietro. La risata di Alina ancora mi risuonava nelle orecchie. Uscendo incrociai sua madre che aveva assistito al nostro incontro nascosta dietro la porta, ed ora era lì, nell'angolo, con le lacrime agli occhi.
Non mi fermai a parlarle. Scesi di corsa le scale, inciampai e caddi quasi. Attraversai il soggiorno in fretta. Suo padre era nella stessa posizione in cui l'avevo lasciato: con la bottiglia in mano, incassato nel divano, coi bagliori della televisione che gli accendevano il viso. Dalla camera di Victor la musica continuava instancabile, indifferente a quanto stava accadendo; mi seguì fino al corridoio, attraverso l'atrio buio, oltre la porta che mi chiusi alle spalle.
Fuori era notte ormai. Nevicava. I fiocchi scendevano fitti assorbendo i suoni, accumulando il bianco nella strada, eliminando contorni, differenze. Il vento spazzava i fiocchi con violenza. La stanchezza che già si era impossessata di me quando ero ancora nella camera di Alina si fece più pressante ora, accumulandosi al freddo pungente.
Mi incamminai verso casa con lentezza lasciando che la neve mi avvolgesse. Incrociai poche persone; invano cercai i loro occhi. Avevano facce puntate a terra a inseguire il movimento dei loro passi. Mi venivano incontro, scivolavano via come se non si accorgessero di me, come se io non esistessi. Le luci dei lampioni proiettavano la mia ombra sulla neve, ed era un'ombra sottile, invisibile quasi.
Camminavo; percepivo lo scorrere lento del sangue alle tempie. La stanchezza mi avvolgeva, mi tagliava le gambe, la sentivo arrampicarsi nel mio corpo e soffocarmi dentro. Lentamente.
Proseguire diventava sempre più difficile e avrei voluto fermarmi a riposare, sdraiarmi nella neve e aspettare. Ma aspettare cosa? Cosa?
Continuai a camminare, e il freddo mi penetrò nelle ossa, e le dita, nel freddo, sembrarono distaccarsi da me, separarsi dalle mie mani, distanti. |